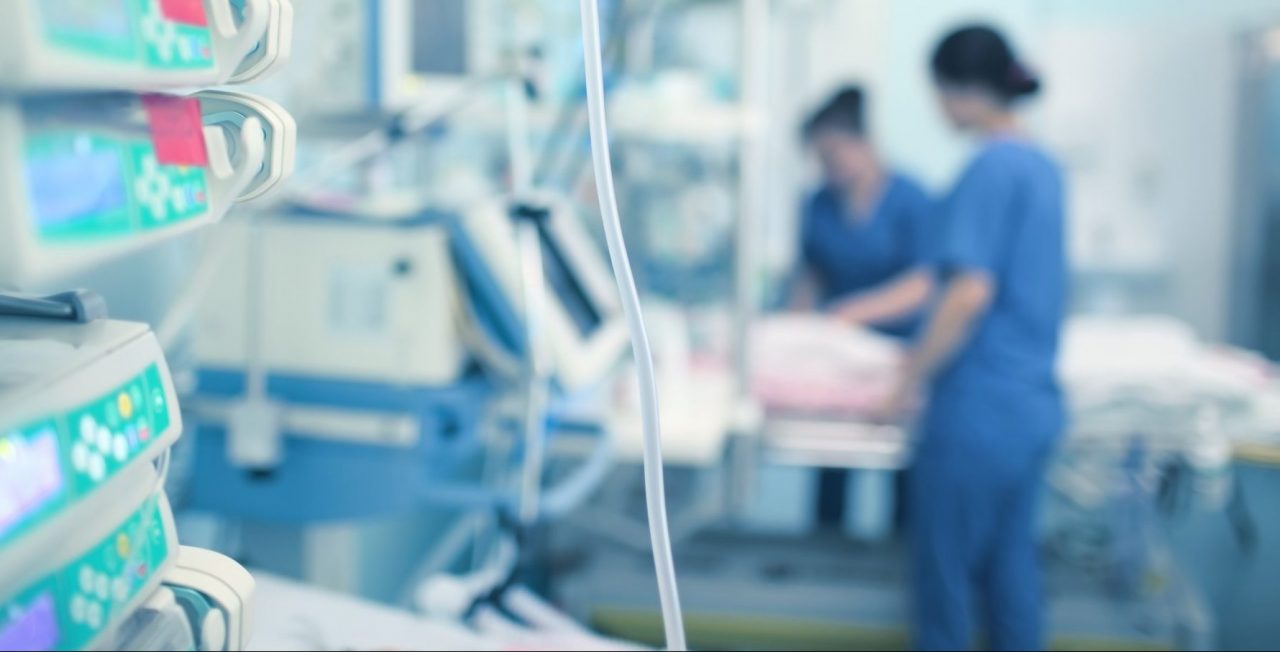Occhi negli occhi, mani che cercano mani. La paura della morte incombente e quei piccoli gesti in grado di cancellare solitudine e sconforto. Medici, operatori sanitari. Uomini e donne in trincea. Professionisti, ma anche persone in cui si annodano sentimenti ed emozioni. Lavorare in un Pronto soccorso Covid-19, come quello dell’ospedale di Circolo di Varese, è come entrare in un mondo parallelo, dove la speranza, la tragedia, la sconfitta, ma anche la forza d’animo e la voglia di non arrendersi mai, si mischiano insieme, in un nodo impossibile da sciogliere.
“In ospedale tengo la mano a chi soffre”: la missione della dottoressa Vella

«Prima di andarsene i pazienti ti parlano – esordisce Morena Vella, 49 anni, residente a Lurate Caccivio e medico all’ospedale di Circolo dal 2001 – Non ti parlano con la bocca, lo fanno con gli occhi. Ti cercano con la mano. Desiderano un contatto, una stretta salda. E noi, tutti noi che operiamo in ospedale, cerchiamo di dargliela».
Perché questo maledetto coronavirus non solo ti distrugge i polmoni, ti azzera il respiro e ti fa schizzare la febbre alle stelle. Questo maledetto coronavirus sfibra rapporti costruiti durante tutta una vita, lasciandoti solo e inerme. «Ci sono tante solitudini, ci sono quelle dei malati Covid, ma ci sono anche quelle degli altri pazienti che non possono ricevere visite. E poi, dall’altra parte, ci sono bellissime relazioni speciali che nascono proprio in ospedale, grazie a gesti quotidiani quantomai importanti». Un lavoro complesso quello di Vella, che deve contenere bene e male. Sia tra le mura del nosocomio, sia quando fa ritorno alla sua abitazione. «In ospedale, a Varese, siamo una famiglia in cui tutti si adoperano per le persone ricoverate – prosegue Vella – Poi, quando si torna a casa si è nuovamente soli. Personalmente cerco di lasciarmi il turno (12 ore di notte e sette di giorno, ndr) alle spalle, anche se in realtà, inconsciamente, i miei pazienti li porto a casa con me. Con le loro storie».
Una normalità dai contorni sfocati. «Cerco di adottare tutte le precauzioni possibili. Insieme a me vivono altre persone e faccio attenzione a non condividere gli ambienti, dormiamo in camere lontane per evitare che possa essere io stessa fonte di contagio. Anche questo fa parte di un impatto emotivo fortissimo che incombe nella quotidianità». Il giusto riposo, con la testa altrove, ma con il cuore rivolto all’ospedale. Fino all’inizio di un nuovo turno. «Le precauzioni sono ai massimi livelli fin dal momento della vestizione, prima di entrare dove sono ricoverati i malati di coronavirus: si indossa la tuta, due paia di guanti, mascherina Ffp2, occhiali protettivi, visiera e calzari. E’ una procedura standardizzata, compiuta a ritroso quando si smonta. Ed è anche in quei momenti che bisogna prestare tutta l’attenzione possibile. Si cerca, persino, di evitare spostamenti d’aria. Ormai sono quasi due mesi di questa routine e non si possono cancellare i pensieri rivolti alla propria salute». Uomini e donne preparati, sottoposti a un grandissimo stress, in cui l’empatia gioco un ruolo essenziale. «Bisogna essere empatici anche se ti mette a dura prova. In 20 anni di lavoro ho visto persone morire, ma di Covid è totalmente diverso: è tutto più acuito». Una lama di rasoio. «Quando non c’è più nulla da fare cerchiamo di alleviare la sofferenza, perché questa malattia ti porta via mentre sei lucido, mentre ti rendi perfettamente conto di quello che sta accadendo. Ci sono le terapie di accompagnamento, certo. Ma bisogna saper comunicare con gli occhi, rispondere agli occhi dei malati, stringere la mano di una persona che da lì a poco morirà». E l’altra faccia della medaglia sono i parenti. Inermi anche loro. In attesa, sospesi in un tragico limbo.
«E’ sempre difficile dire a un figlio o a una figlia che suo padre è morto, ma a volte si hanno risposte che ti spiazzano. Qualche giorno fa, durante una di queste telefonate mi è stato detto: “La ringrazio perché so che lo ha accompagnato in questo viaggio e non lo ha fatto soffrire… grazie della sua umanità e porti i miei ringraziamenti a tutti voi che in questo momento ce la state mettendo tutta e state facendo un gran lavoro”. Ecco, sono parole come queste, seppur nella sofferenza che vedo e percepisco, che rendono la mia giornata degna di essere vissuta».
(Giornale di Olgiate, sabato 18 aprile 2020)